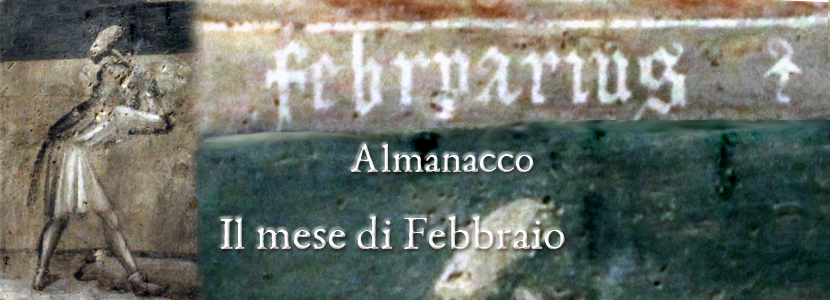
I SANTI DEL MESE: FEBBRAIO
Questa rubrica trae spunto dalla descrizione di quelle “santità” che hanno avuto una particolare venerazione in Brianza. La loro ricorrenza, oltre ad una valenza religiosa, aveva un differente, se non ancora più importante valore nello scandire lo scorrere quotidiano della vita dei contadini, calendarizzando quelle attività che segnavano l’annata dei lavori della terra. Un connubio portatore altresì, di una fioritura di proverbi altrettanto pregni di cultura contadina, sia intesa come “saper fare”, ma soprattutto come solidità morale nell’attribuire un valore concreto agli accadimenti della vita.
FEBBRAIO
A farci da guida il solito terzetto, Sandro Motta, capostipite nel raccontare le tradizioni della Brianza di una volta, Flavio Ronzoni, che ribadiamo, solo saltuariamente cita il precedente, pur avendolo saccheggiato a piene mani in diversi suoi scritti, anche se a onor del vero aggiunge talvolta suoi contributi alla ricerca. Per finire Franca Pirovano, attenta conoscitrice delle tradizioni brianzole, per restituire sempre contenuti pensati e pertinenti.
Febbraio, nel dialetto “Febrar” o anche il più antico “Fevree”, che abbiamo incontrato in quella ripetuta invocazione del “ul Ginée …al va in Fevrée …”.
Per iniziare qualche proverbio in vernacolo locale, in chiave meteorologica: “A la Madona de la Scerioela (2 febbraio) de l’inverno semm foera, ma se l’é seren, semm dent pùssee ben”. (Alla madonna della ceriola dall’inverno siamo fuori, ma se è sereno, siamo dentro ancora meglio). Quindi, stupenda giornata di sole il 2 febbraio 2020, dobbiamo attenderci una recrudescenza dell’inverno, che finora si è visto molto poco.

fotografia di Luca Fantoni
E’ ancora Sandro Motta che inanella questa sequenza di modi di dire: “A Febrar i merli vann in paar”. “Febrar febraett, tutt i gain fann l’uvett … E poi: “Aqua de Fevree la impiendiss ul granee”. “Febrar se l’é piuvent el fà ul vilan cuntent”. Riassumendo, è il risveglio della natura che si annuncia con l’accoppiamento dei merli, le galline del pollaio sono tutte attive nel deporre le uova e nota dolente alla luce della mancanza di pioggia che ha segnato questo ultimo mese e come sottolineavano i contadini, la necessità di piogge nel mese di febbraio per garantire raccolti copiosi.
Il Ronzoni, parlandoci per proverbi, aggiunge: In realtà, la fine dell’inverno era ancora lontana e i proverbi non mancavano di sottolinearlo con pratico realismo (“Febrar febraett, curt ma maledett”), pur ricordando al contadino di preparare gli attrezzi, per ritornare ai lavori nei campi (“A San Faustin prepara ul zapin”).
Seguiamo ancora il Ronzoni, che ci svela in chiave botanica alcuni segni della natura che meritano di essere colti. Così alle prime margherite, primule e fiori di veronica (ugitt del Bambin), si aggiunge il bucaneve ed è proprio questa essenza a farci conoscere una tradizione passata, per bocca del Ronzoni apprendiamo: “Il bucaneve (Galanthus nivalis) era anche beneaugurante, e non solo in Brianza; una diffusa tradizione popolare vuole che un bucaneve raccolto nella prima notte di luna dopo la fine di gennaio porti bene per tutto l’anno. Un mazzetto di bucaneve raccolti di prima mattina e gettato in un ruscello poteva prestarsi a trarre auspici di carattere amoroso: se l’acqua trascinava lontano i fiorellini, l’affetto dell’amato era assicurato per sempre, ma se il mazzetto tornava a riva occorreva rassegnarsi ad un amore non corrisposto.”

fotografia di Luca Fantoni
Queste varietà precoci di piccoli fiori prendevano, in funzione del momento in cui fiorivano, prossimo al giorno della Candelora, il nome di “i fiur de la Scerioela”. Era tradizione, da parte delle fanciulle, raccogliere questi fiori e donarli in occasione di questa scadenza alla Madonna. Il significato della purezza di cui le giovani erano portatrici, rimandava appunto alla festa di purificazione della Madonna.
In occasione delle varie ricorrenze, sarà pubblicato il relativo contenuto
La ricorrenza della Candelora, in Brianza più nota come “la Madona de la scerioela”.
Ricordo da piccolo, quelle due candele che pendevano, mi sembra legate tra di loro nella camera da letto di alcuni nostri conoscenti, un po’ avanti con gli anni, che abitavano una casa, che nella mia visione da bambino, mi appariva alquanto tetra. Una scala all’interno dell’androne sempre poco illuminato mi conduceva in quell’abitazione e subito varcata la soglia sul mobile di legno scuro la figura di un coccodrillo in legno con le fauci aperti, che ho saputo anni dopo essere un dono di un parente missionario in Africa. Ecco che questa visione per me all’epoca alquanto cupa, non so per quale motivo, faceva poi il paio con quelle due candele appese nella stanza da letto, il cui accesso mi era permesso solo per il mio status di bambino. Non ho mai chiesto, a quel tempo, quale fosse la “funzione” delle due candele, del resto mi bastava quel disagio che mi procuravano quei due luoghi della casa dello “zio Cecchino e della zia Gina”, che parenti non erano, per spingermi a defilarmi al più presto, da quelle sensazioni.

Quali simulacri fossero le candele, ce lo spiega Flavio Ronzoni.
La ricordanza va al IV secolo quando in Oriente si celebrava la “Presentazione del Signore”, a ricordo come citato dal Vangelo della presentazione di Gesù al tempio. Una legge ebraica prevedeva che il primogenito venisse consacrato al Signore presentandolo al tempio nel quarantesimo giorno dalla nascita; nella stessa circostanza avveniva la purificazione della madre. (Tale consuetudine, che vedeva la madre dopo il parto recarsi in chiesa per questo rito, era ancora praticata nelle nostre chiese negli anni Sessanta). Il Ronzoni continua: “La Chiesa romana, nel VII secolo, fissò la data della celebrazione al 2 febbraio, tenendo conto che proprio a quella data erano passati 40 giorni dal 25 dicembre. In questo modo, però, la festa venne a coincidere con il mese che nell’antica Roma era destinato alle purificazioni e che aveva inizio con una festa dedicata a Giunone Salvatrice. A questo punto i cristiani di Roma, per evitare possibili sovrapposizioni e confusioni con sopravvissuti elementi di paganesimo, pensarono di dare alla festa il nome di “Purificazione della Beata Vergine”, mettendo in secondo piano la denominazione originaria.”
La consuetudine d’introdurre le candele nel rito sembrerebbe, sempre a detta del Ronzoni, importata dalla Francia tra il IX e X secolo, mutuato dal rito pasquale dell’accensione delle candele, nel significato della luce che Cristo diffonde.
In occasione dunque della “Madona de la Sceriola”, le donne con la benedizione che ricevevano ricordavano la purificazione della Madonna, durante la presentazione di Gesù al tempio.
Ancora il Ronzoni: “La benedizione delle candele, che era in realtà un momento marginale nell’ambito della festa, venne invece ad assumere nella tradizione brianzola un notevole rilievo, tanto da segnarne la denominazione (sceriola, o ciriola, deriva da “cera”); di solito ogni donna acquistava due candele benedette in questa occasione e le portava nella propria casa, collocandole a capo del letto matrimoniale. Queste candele venivano accese solo in occasioni speciali, che richiedevano un intervento celeste particolarmente forte: quando giungeva in casa il sacerdote per l’estrema unzione, quando si doveva chiedere la guarigione di un malato, per cui si invocava soprattutto San Rocco, oppure per chiedere la protezione sul bestiame o sul raccolto in pericolo”.
Ricordiamo che con l’avvento del Concilio Vaticano II, si ritorna alle origini e la “Candelora” si riappropria dell’antica denominazione di “Presentazione del Signore”, le candele sono solo benedette e non più accese durante il rito.
Sandro Motta ricorda: “Nella nostra Brianza era invalsa l’abitudine che tutte (ma proprio tutte) le madri di famiglia si recassero “a fass benedì un’altra voelta e a ciapà la candila” a Viganò Brianza dove dicevano ci fosse un vecchissimo curato taumaturgico”.
C’è un proverbio brianzolo, che tira in ballo San Biagio: “Se in cà te g’heet San Bias (la salute), la dona che tas e ul burzott ras, te poe viv in pas”. Il riferimento al santo rimanda alla sua protezione per la salute anche se nello specifico ricordiamo san Biagio, annoverato fra i 14 Santi “Ausiliatori”, per il mal di gola e la pertosse.
Ricorda il Motta, a proposito di questa protezione generica della salute, come san Biagio prima di diventare vescovo, avesse esercitato la professione di medico. Vescovo a Sebaste in Armenia e quindi costretto alla fuga durante le persecuzioni in Oriente di Licinio.
Tra i miracoli tramandati la guarigione del giovane che rischiava la morte per la spina che aveva in gola.

La vecchia chiesa di san Biagio a Monza crollata nel 1977
A Monza da tempi antichi esiste il quartiere di San Biagio, appunto per la presenza della chiesa dedicata al santo. La costruzione religiosa che oggi troviamo nel quartiere, d’impronta moderna, è l’ultima discendente degli edifici dedicati al culto del santo che si sono succedute durante i secoli. Ricordiamo il crollo dell’antica chiesa di San Biagio nel 1977, quando tuttavia le celebrazioni erano già state trasferite nella nuova struttura. Fu dopo tale evento che diversi affreschi furono “strappati” dal vecchio edificio e collocati nel nuovo tra questi un frammento di pittura che ricorda la leggenda che voleva il santo visitato da bestie feroci, nella grotta dove dimorava, e attendevano che san Biagio terminasse le sue preghiere, per essere poi curati dalle ferite che si erano procurati.

Affresco di Antonio De Grada 1894, proveniente dalla crollata chiesa di San Biagio e traslato nel nuovo edificio
Sempre Sandro Motta in funzione di queste frequentazioni di lupi e orsi, rimanda a quell’alone di mistero che aleggia attorno al santo.
Nella Brianza di un tempo era tra le altre minacce rivolte ai bambini per tenerli buoni, una che rimandava a san Biagio: “Varda che ghe disi a San Bias de fa vegni chì ul luf … “. (il lupo), in una associazione che proponeva il lupo ma anche san Biagio, nella stessa ombra di paura, che la minaccia degli adulti aveva ingenerato nei bambini. Il Motta afferma che ancora, ai tempi del suo scritto “Del tecc in su”, anni Novanta del Novecento: “In certe zone della nostra Brianza ul luf de San Bias figura ancora fra gli spauracchi dei bambini!”
Flavio Ronzoni, annovera san Biagio, quale protettore degli agricoltori.
Ricordiamo ancora oggi la benedizione impartita dal sacerdote, con l’ausilio delle due candele incrociate, benedette il giorno avanti (la Candelora) con le quali tocca la gola di fedeli in segno di protezione. Senz’altro più conosciuta la tradizione della fetta di panettone, conservata da Natale, che perpetra la stessa protezione. Questo nel solco, vivo un tempo, della convinzione dei valori taumaturgici che si attribuivano a quegli elementi simbolici, la fetta di panettone, piuttosto che qualche frammento del “ciocco di Natale”, che appunto conservati da quel momento sacro e solenne, avrebbero potuto essere sicuro rimedio nelle difficoltà dell’anno a venire. Il ciocco contro le tempeste dell’estate, il panettone contro il mal di gola.
Questa mattina ho raggiunto Monticello, per verificare di persona, se ancora qualcosa sopravvive di quelle ricorrenze che nel calendario di una volta erano veramente sentite.

La Parrocchiale di Monticello, dedicata a Sant’Agata
Della cronaca fatta da Sandro Motta negli anni Novanta del secolo scorso, sopravvive e per fortuna, lo spirito religioso della ricorrenza. Verso le 10 una folla abbastanza nutrita, entrava nella chiesa e nell’attesa della funzione celebrata dal sacerdote, l’assemblea faceva risuonare, ora da un lato ora dall’altro, l’intercalare delle “Ave Maria”. Sulla salita che conduce alla chiesa, l’indicazione di una cena da consumarsi questa sera, con l’invito per dare la propria adesione, rivolto a chi avesse voluto partecipare. L’aspetto esteriore della ricorrenza si ferma qui. Il Motta raccontava di una celebrazione riservata alle sole donne a cui non era ammesso nemmeno il sagrestano. Oggi questo ostracismo è dimenticato. E’ dimenticata e lontana anche la presenza dei “firunatt” (venditori di filze di castagne cotte al forno). Solo per quella necessità di documentare come si “colorava” il dopo celebrazione, riportiamo il racconto di Sandro Motta: “Il “firon” veniva giocato alla “balutera” (sacchetto con palline numerate da 1 a 90). La posta di rito era “cinqu ghei tre ball” (cinque centesimi tre palline). Il giocatore mescolava energicamente con la mano destra le palline nel sacchetto e ne estraeva tre. Se la somma dei tre numeri estratti era inferiore a 100, aveva vinto; altrimenti, sé voleva, poteva ritentare, pagando però altri cinque centesimi.

L’altare dedicato alla santa all’interno della Parrocchiale di Monticello
Per il fatto che il sacchetto delle palline avesse in dialetto la stessa denominazione che si dava allo scroto o alla sua parte corrispondente dei pantaloni, le donne non ci mettevano mai la mano dentro, ma facevano mescolare ed estrarre le palline dal “firunatt” … A Monticello però capitava sempre che qualche “spusotta surevana” (sposotta strafottente) osasse mescolare personalmente con la mano le palline nella “balutera “, fra le risate sguaiate e gli sberleffi delle astanti.
Al povero “firunatt” allibito non rimaneva che pronunciare solennemente l’ironica frase di rito in simili circostanze: “Sta certa, dona, che gh’el disaroo mai al to’ omm che t’heet mettuu dent la man in de la mia balutera”…
L’aperta allusione a contenuti di natura sessuale, così come il comportamento provocatorio, della “spusotta surevana” a cui il Motta si riferisce, rimanda come afferma Franca Pirovano: “a quella licenziosità di comportamenti e di parole che si spiega con il valore bene augurante che ogni riferimento verbale alla sessualità magicamente possiede.”
La festa era riservata, come abbiamo detto unicamente alle donne che allattavano al seno, delle quali Sant’Agata era la protettrice, la sua protezione di estendeva sulle donne in generale, ma in particolare sulle balie e le nutrici.

Una vetrata della chiesa di Monticello, su cui è riprodotta Sant’Agata
Ci affidiamo al Ronzoni per sapere qualcosa in più sulla santa: “…la vergine catanese, il cui nome in greco significa “buona”, fu martirizzata nel III secolo tra crudeli torture, tra le quali il taglio dei seni, particolare, questo, che trovò speciale risonanza non solo nella tradizione popolare, ma anche nell’iconografia dei secoli passati, che raffigurò spesso la santa con le mammelle posate su un piatto (appare così anche in alcuni santini diffusi fino a qualche decennio fa). La santa ebbe grande fortuna anche nella nostra regione, dove era invocata soprattutto dalle donne che allattavano al seno.” Oggi la santa è accostata anche alla specifica protezione di chi ha subito interventi al seno, in quell’ineluttabile aggiornamento di costumi, in cui anche le malattie tanto invasive, con cui dobbiamo fare i conti, non sono da meno.
Santa Apollonia, nella Brianza a noi prossima, si lega immediatamente alla località di Viganò. Oggi ricordata soprattutto per la “Sagra del raviolo dolce”, è inoltre uno dei pochissimi luoghi, in cui il giorno della ricorrenza, si trova un numero di bancarelle degne di rappresentare una “sagra”.

La chiesa di Viganò, con la facciata in fase di restauro
Che poi la maggior parte delle merci esposte sia in linea con i tempi attuali, è altrettanto innegabile. E’ comunque assicurata la presenza del “firunatt”, che era una costante in tutte quelle ricorrenze che stiamo elencando in questa rubrica.

“Firunatt” e “raviolo dolce” un connubio per Santa Apollonia
Per aggiungere qualche contenuto d’interesse dobbiamo ancora una volta, fare diversi passi indietro nel tempo e affidarci a Sandro Motta, che a sua volta racconta di cose ancora più vecchie. Il suo riferimento temporale è sempre: “ai temp del Re de Sass” (Vittorio Emanuele II 1820-1878).
Dunque in quel tempo Santa Apollonia, nella Brianza era la patrona degli innamorati, poi soppiantata dal consumistico San Valentino, celebrato quindi solo qualche giorno dopo, sempre nel mese di febbraio.
Il racconto del Motta parla di una curiosa e singolare consuetudine a proposito del corteggiamento. Ecco il racconto: “Il giorno della festa da noi si usava “nà a Viganò a bulà la spusa”.
Ecco un glossario minimo per la comprensione del discorso: bulà = colpire con una palla di neve; tusa bulada = ragazza colpita, ossia scelta ufficialmente dal giovanotto, e quindi ragazza felice; fass bulà = farsi colpire, in tutti i modi, anche con certe astuzie nelle quali le ragazze brianzole erano espertissime. (Insomma: il fine giustificava i mezzi)…I due (innamorati o presunti tali) si trovavano sul piazzale della Chiesa di Viganò come capitati lì per caso, essendo arrivati in due comitive separate “de bagai e de tusann”.
Il gioco del “bulass” aveva inizio subito dopo le sacre funzioni…
Capitava che la ragazza (la tusa bulada”) e in particolare se la stessa sapeva di non essere particolarmente avvenente, “sprizzasse” una felicità incontenibile, che esternava con clamore gridando: “Sun stada bulada! Sun stada bulada!”.
Oltre alla componente affettiva della ragazza innamorata, che trovava un’anima gemella, non dobbiamo dimenticare la dimensione sociale in cui le ragazze di quel tempo si trovavano e dunque dell’opportunità e della necessità di uscire dalla propria famiglia, circostanza che avrebbe comportato uno sgravio, da un punto di vista economico, per la stessa, e la prospettiva di una nuova vita, sperata migliore della precedente, per la ragazza che andava in sposa.

Fedeli all’interno della chiesa, accendono ceri alla santa
Ritorniamo al Motta che racconta come andavano poi le cose in quel di Viganò:” Probabilmente la “tusa” non aveva visto in faccia il colpitore, ma era certissima che egli si trovava lì, in carne ed ossa, e che presto o tardi sarebbe venuto da suo padre a chiedere la sua mano con la frase di rito: “Regiuu, vurarii spusà la vosta tusa … ” Poi magari capitava che la “bulada” era stata fasulla e lei avrebbe fatto la marela, ma ciò non toglieva l’ebbrezza di essere stata colpita!”
Il “colpitore”, quasi sempre si palesava immediatamente, visto che il gesto aveva spesso un significato simbolico, che dava ufficialità ad un rapporto già consolidato.
Sempre il Motta: “(Il giovane) s’avvicinava alla futura sposa con un mezzo sorriso sulle labbra e le diceva semplicemente: “Nemm a tiragh al firon… “. Ricordiamo la “balutera” che abbiamo raccontato per Santa Agata.
Dopo un po’ li vedevi passeggiare soli, un poco discosti dagli altri: lui col cappello in bilico sulla nuca (alla maniera degli uomini sposati) e lei con il lungo “firon” al collo.”
Ancora il Motta con una punta di perfidia ci racconta con un proverbio, che se il matrimonio non fosse stato proprio perfetto, una via d’uscita c’era: “Se te voeret restà senza miee, (moglie) mette la al suu ul mes de Fevree”.
Santa Apollonia, nella sua veste ufficiale è implorata da chi soffre di mal di denti è di conseguenza risulta protettrice dei dentisti.
Tale patronato che si lega al suo martirologio, ricorda la tortura inflittale dopo la cattura, per la sua fede cristiana, che non volle abiurare.
Particolarmente cruento il suo martirio, avvenuto ad Alessandria d’Egitto, al tempo dell’imperatore Decio. I persecutori, prima le estrassero tutti i denti, poi, minacciarono di bruciarla viva, se non avesse pronunciato con loro empie parole, risoluta Santa Apollonia sfuggi dalle mani dei carnefici e si gettò nel fuoco, trovando la morte.

Un dipinto di Santa Apollonia nell’arco tra navata e abside all’interno della chiesa di Viganò
Il particolare dei denti strappati ritorna nell’iconografia dell santa, raffigurata con un tenaglia che trattiene un dente. Nella citata chiesa di Viganò, la santa è venerata attraverso un culto sentito, all’interno dell’edificio religioso è rappresentata con una statua e un dipinti, collocato nella parte sinistra dell’arco che divide la navata dall’abside. Santa Apollonia ha, se non soppiantato, almeno messo in disparte, il compatrono del paese, san Vincenzo di Saragozza, martire spagnolo del IV secolo al quale era dedicata la chiesa di Viganò già nel XIII secolo. L’attuale edificio fu costruito nel 1567, rimesso a nuovo e portato nelle dimensioni attuali nel 1909, epoca a cui risale la statua di sant’Apollonia.
Segnaliamo ancora una rappresentazione della santa, nella chiesetta di Campofiorenzo a Casatenovo.
Concludiamo, sempre grazie a Sandro Motta, ricordando una scadenza legata alle attività contadine di un tempo. Fonte di sussistenza nelle nostre campagne era senz’altro la coltivazione della patata e a questa essenza si rifà il racconto del Motta: “Nelle nostre campagne “vers Santa Pulonia” il “regiuu” mandava in “cà strascia” le donne anziane della famiglia a fare la cernita delle patate da trapianto. Bisognava cioè scegliere fra i tuberi quelli con l’occhio (cioè la gemma) che avrebbe fatto la nuova pianta. Era un lavoro di estrema accuratezza. Nel terreno andava l’atavi, cioè la fetta con l’occhio. Le parti rimanenti venivano cotte per il maiale.”

Santa Apollonia nella raffigurazione nella chiesetta antica di Campofiorenzo
Tale consuetudine risulta oggi dimenticata, anche da chi per il proprio uso personale “fa l’orto”. Con il bombardamento di radiazioni che subiscono i tuberi prima di finire sul mercato e quindi sulle nostre tavole, difficilmente le patate sono in grado “de fa l’oecc”.
Aspetti, località e storia della Brianza. "Ci sono paesaggi, siano essi città, luoghi deserti, paesaggi montani, o tratti costieri, che reclamano a gran voce una storia. Essi evocano le loro storie, si se le creano". Ecco che, come diceva Sebastiano Vassalli: "E’ una traccia che gli uomini, non tutti, si lasciano dietro, come le lumache si lasciano la bava, e che è il loro segno più tenace e incancellabile. Una traccia di parole, cioè di niente".